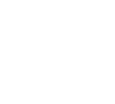Guillaume Tell in streaming “Quel horizon immense!”
Lo streaming sarà disponibile su OperaVision dalle 19:00 del 7 aprile.
Quel horizon immense!
Non è biografia romanzata né fantascienza musicologica immaginare che al capolinea del Guillaume Tell Rossini pensasse fin da quell’agosto 1824 in cui, accettando la nomina a sovrintendente del Théâtre Italien offertagli dalla Corte e dal ministero delle Belle Arti, diveniva l’anello di turno di quell’ininterrotta catena di operisti italiani che da Piccinni in poi si erano identificati nella rigenerazione della tragédie lyrique, giunta con Spontini alla sua estrema espressione storica e insieme alla sua saturazione stilistica. A considerare quanto precedette quella serata del 3 agosto 1829 all’Académie Royale de Musique con un occhio alla parabola del musicista e l’altro alla dimensione psicologica dell’uomo, non è infatti arbitrario ravvisarvi un vasto panorama cui sovrasti l’ombra densa e sempre più inquietante di un imminente nubifragio.
Che altro è quel prender tempo (tirando per le lunghe la definizione del proprio contratto in un estenuante braccio di ferro con l’amministrazione) attorno ai rifacimenti francesi del Mosè in Egitto e del Maometto II – grandiosi e drastici rifacimenti, ma non novità di zecca –; che altro è quel rimpasto che trasformerà gli estremi, scintillanti rossinismi della celebrativa cantata scenica Il viaggio a Reims nel metarossinismo freddo e ambiguo de Le Comte Ory, se non l’ansiosa attesa di una vibratile creatività che sente incombere su di sé il rendiconto finale delle proprie responsabilità creative?
Era ben chiaro infatti, alla coscienza di un artista non lontano dal venire inchiodato da uno stolto pregiudizio critico allo stoltissimo stereotipo del facitore di musica allegramente spontaneo e naïf, che l’inevitabile impegno professionale di un’opera francese tutta nuova e attesa dall’opinione pubblica con crescente impazienza, sarebbe stato di gran lunga il più traumatico e defatigante in una carriera vorticosa e disseminata di ansie e paure del foglio bianco, passate all’aneddotica come cronica fannullaggine. Non si sarebbe più trattato, infatti, della periodica impennata temeraria che lungo una linea perpetuamente segmentata aveva prodotto (limitandoci al genere serio) cose abnormi come Otello, Mosè, Ermione, La donna del lago, Maometto II, Semiramide; non della sfrenata sperimentazione per le scene di un teatro, come il San Carlo, che poteva dirsi in quegli anni eroici di sua proprietà personale. Ad attenderlo al varco era bensì un prodotto da collocare nell’ambito di una civiltà melodrammatica dai connotati non eludibili, in un teatro dai meccanismi rigidamente istituzionalizzati, per un pubblico savant (Verdi) e con uno stragrande concetto dei propri giudizi e pregiudizi, comunque ben diverso da quello italiano, che ieri ti aveva fischiato e oggi ti staccava i cavalli dalla carrozza.
E capolavoro voleva essere: a tutti i costi. Eccola, in definitiva, la Sfinge tremenda in attesa del nostro Edipo alla svolta fatale. Ce n’era abbastanza per un ingorgo di nevrosi tale da dare la più ampia spiegazione al presunto mistero del Grande Addio al teatro, addio che il Nostro già si premurava di preannunciare in ambigue mezze frasi. Un assaggio di queste ansie in gran parte di nuovo conio gli viene subito dal libretto, il cui soggetto, il mito di Wilhelm Tell nel quadro storico della emancipazione elvetica dal dominio asburgico, si addiceva a quella curiosa brezza indipendentistica che in quegli anni increspava le acque della Senna e che già aveva gonfiato le vele de Le siège de Corinthe: un’aria che non contraddiceva affatto all’oltranzistico illiberalismo di Carlo X, essendo semmai favorita dai suoi gallicani puntigli nazionalistici e dalla speranza (poi andata delusa) della Corte di sistemare un Borbone sul trono di una Grecia prossima a liberarsi dalla Sublime Porta.
Per questo soggetto, adocchiato fin dal 1827, Rossini aveva scartato un Gustave III e una Juive (in seguito musicati rispettivamente da Auber e da Halévy) propostigli tramite l’amministrazione dal premiato atelier Scribe, lo stesso dal quale era uscito l’Ory. L’autore di base del nuovo libretto, Victor-Joseph-Étienne Jouy (1764-1846; il “de” aristocratico è una licenza autopromozionale e fa il paio con quella di Calzabigi) era un teatrante della passata generazione, noto come collaboratore di Méhul, Catel, Cherubini e soprattutto Spontini, cui fornirà i testi di Milton (con Joseph-Marie Dieulafoi), La vestale, Fernand Cortez (con Joseph Esménard), Pélage, ou Le Roi et la Paix. Non nuovo a intendersela con Rossini per avere, tra l’altro, messo mano al rifacimento del Mosè in Egitto in Moïse, col poème di Guillaume Tell Jouy concluderà una carriera intrapresa all’insegna dell’opéra comique e approdata alla dignità dell’Académie Française e della ufficialità letteraria francese.
Ma Rossini non accetta tal quale quel lungo dramma scritto anni prima e non più rispondente alle nuove esigenze spettacolari dell’Opéra, per tacere di quelle personali del compositore. Sarà Hippolyte-Louis-Florent Bis (1789-1853), orleanista dichiarato e autore di scritti giornalistici e di tragedie ideologiche sempre nel mirino della censura, a sfoltire il testo di Jouy e ad apportarvi le modifiche richieste, cospicue soprattutto negli ultimi due atti. Al dire di Edmond Michotte, nell’estate del 1828, a composizione musicale già intrapresa nella residenza estiva del banchiere Alexandre Aguado, Rossini avrebbe inoltre richiesto l’aiuto di una terza e di una quarta mano, quelle di Armand Marrast, segretario del banchiere Aguado, e di Adolphe Crémieux, suo ospite occasionale. Due altre teste calde, «futurs conspirateurs contre le gouvernement de Louis Philippe, qui se trouvant également en villégiature chez Aguado, me vinrent en aide, dans les transformations du texte et de la versification qui m’étaient nécessaires, pour ourdir, comme il le fallait, le plan de mes conspirateurs à moi contre Gessler»: parole del Maestro a Wagner, riportate nella storica conversazione raccolta da Edmond Michotte nel 1860 e pubblicata nel 1906. Una testimonianza che verrà accolta da tutta la bibliografia rossiniana, ma che Elizabeth Bartlet, curatrice dell’Edizione critica dell’opera, ha giudicato inattendibile, accreditando piuttosto l’ipotesi che a dare gli ultimi ritocchi al libretto possa essere stato il primo Arnold, quell’Adolphe Nourrit stimato come persona dotata di talenti letterari, «que j’ai nommé depuis longtemps mon poète adjoint», come Rossini medesimo si compiacque di definirlo in una lettera a Bis.
L’accanimento rossiniano sui versi originari di Jouy era certo proporzionale alla crucialità di un impegno compositivo che già ardeva alto nel cuore dell’artista. Ma non dovrà stupirci più di tanto, consapevoli ormai dell’atteggiamento tutt’altro che indifferente o passivo assunto anche addietro dall’operista nei confronti dei suoi poeti di teatro italiani. La composizione dell’immensa partitura si protrasse ben oltre quell’ottobre 1828 previsto da Rossini come termine del «difficile e lungo lavoro», anche per il puntiglioso contendere (conclusosi solo l’8 maggio del nuovo anno in favore del richiedente) tra l’amministrazione e il musicista che aveva chiesto radicali modifiche al contratto originario: composizione di un’opera ogni due anni per 15.000 franchi oltre alle beneficiate (l’intero incasso di una serata) e un vitalizio annuo di 6.000 franchi.
Si giunse così alla sera del 3 agosto, tra l’attesa bruciante di un tout Paris che aveva espressamente rinunciato alla villeggiatura. Gl’interpreti erano il basso Henri-Bernard Dabadie, protagonista, il tenore Adolphe Nourrit (Arnold), il basso Nicolas-Prosper Levasseur (Walter Furst), il basso [?] Bonnel (Melcthal), il basso Alexis Prévost (Gesler), il tenore Jean-Étienne Massol (Rodolphe), il tenore Alexis Dupont (Ruodi, il pescatore), il basso Ferdinand Prévost (Leuthold), il soprano Laure Cinti-Damoreau (Mathilde), il soprano Louise-Zulme Dabadie (Jemmy), il soprano [?] Mori (Hedwige). Direttore e concertatore era Antoine-François Habeneck, il neo-fondatore della Société des Concerts du Conservatoire (1828) con la quale si era fatto promotore della rinascita di una cultura sinfonica mediante l’esecuzione delle opere dei classici viennesi. Autore dell’apparato scenografico era Pierre-Luc-Charles Cicéri che si era documentato compiendo un viaggio in Svizzera; i costumi erano di Henri Lecomte, le coreografie (cui prenderà parte la celebre Maria Taglioni) di Jean-Pierre Aumer.
Com’era prevedibile, se di successo si poté parlare, esso fu di stima da parte del grande pubblico, di élite presso gli ascoltatori più responsabili. E già durante le prove avevano avuto inizio le complicate vicissitudini delle varie mutilazioni e manipolazioni cui verrà sottoposta la partitura nel corso del suo cammino sulle scene dell’Opéra (dove, almeno sino al 1876, apparve ogni anno, salvo il 1849, per 617 riprese complessive, ma non sempre al completo dei suoi quattro atti) e degli altri teatri europei. Modifiche cui in parte provvederà l’autore (approntando anche una riduzione dell’opera in tre atti) allo scopo di evitare il peggio dovuto ad altre mani, e circa le quali è difficile sceverare le ragioni eminentemente estetiche da quelle dovute a forza maggiore. Sarà un teatro secondario, quello del Giglio di Lucca, a sobbarcarsi l’onore e l’onere della prima italiana del capolavoro, nella traduzione di Calisto Bassi.
Come già a proposito del libretto di Otello raffrontato a Shakespeare, sarebbe ozioso impuntarsi sui dirottamenti dalle strutture drammaturgiche e dai contenuti ideali della tragedia di Schiller, operati dai collaboratori letterari di Rossini nel confezionargli un libretto giusta le esigenze della massima istituzione melodrammatica francese. E ciò anche prescindendo dalle contaminazioni (in primo luogo da Jean-Pierre Claris de Florian e dall’opéra comique Guillaume Tell di Grétry e Sedaine) cui Jouy e Bis possono avere sottoposto quella che comunque va considerata la loro fonte primaria. L’idea di libertà quale poteva essere recepita nel 1804, l’anno del Wilhelm Tell schilleriano, da una Germania in un tempo umiliata e ammaliata dall’imperialismo napoleonico, era ben diversa da quella, mutuata dalla grandeur nazionale e dall’espansionismo economico, della borghesia francese della Restaurazione. Inoltre, se in Schiller Wilhelm Tell è il pacifico e schivo padre di famiglia coinvolto suo malgrado nella lotta contro la tirannide a seguito di un imperativo morale scaturito dalla solidarietà con altri umili e semplici, nell’opera di Rossini è l’Eroe a tutto sesto, erede di un epos melodrammatico che ha radici profonde nella tragedia musicale francese e del quale le opere di Spontini erano state la più recente e paradigmatica espressione. Eliminando il personaggio di Werner Stauffacher, che in Schiller è il vero promotore politico della rivolta; ricavando dalla coppia originaria costituita da Ulrich von Rudenz, giovane aristocratico svizzero che vuol far carriera sotto le armi imperiali, e da Bertha von Bruneck, nobile tirolese votata alla causa svizzera, un Arnold, «simple habitant de ces campagnes» che ama riamato Mathilde, principessa asburgica, i librettisti di Rossini adattavano la fabula schilleriana alla coeva ricezione del pubblico, adottando strutture drammaturgiche soltanto in parte debitrici alla tradizione della tragédie lyrique.
Esse, in sintesi, giustappongono al classico, tradizionale eroe dalla virtù carismatica, il topos moderno della coppia travagliata da un amore impossibile che verrà immolato sull’altare, romantico per definizione, della rinunzia, a causa della disparità della condizione sociale e dei divergenti destini politici. Si aggiunga che quell’elemento alpestre che in Schiller è cornice riservata alle affascinanti didascalie e al mondo di personaggi minori dai nomi e nomignoli rustici (dei quali nell’opera il pescatore Ruodi è il solo superstite), nel libretto diverrà quella onnipresente couleur locale che in mano a Rossini si tramuterà magicamente nel respiro cosmico di una numinosa natura.
S’è detto della necessità, da Rossini avvertita e tremendamente sofferta, di una rigenerazione stilistica che in un qualche modo fornisse risposta definitiva alle molte avvisaglie già disseminate nei rifacimenti francesi del Mosè e del Maometto e voltasse pagina nei confronti del rossinismo: quell’eredità a doppio taglio nella quale il Maestro si sentiva catturato come in una gabbia dorata, prima ancora che in tal guisa venisse considerato dalla critica malevola. Colui che veniva ritenuto, ed era a tutti gli effetti, il massimo operista vivente, non poteva semplicemente adattarsi al ruolo di nuovo maestro del melodramma francese, ruolo nel quale era stato preceduto, ciascuno a suo modo, da Spontini e dall’Auber della Muette de Portici.
Non spettava alla tragédie lyrique di acquisire Rossini, ma viceversa. Non va quindi enfatizzato più di tanto il fatto che Guillaume Tell sia ascrivibile de iure all’aulico genere ormai prossimo a spaccarsi come frutto troppo maturo nelle mani di Meyerbeer, divenendo grand opéra. Giacché Guillaume Tell non è prodotto in tutto assimilabile a una tradizione della quale utilizza solo in parte le tipologie e per farne qualcosa di inaudito, e dalla quale, a ben vedere, si discosta in uno dei suoi elementi costitutivi: quell’aulico decoro da gran cerimoniale teatrale, che proprio Spontini nella Vestale aveva clamorosamente restaurato, dopo la svolta intimistico-borghese dei Piccinni e dei Sacchini, e nell’Olympie sublimato.
Mentre il cuore del capolavoro rossiniano batte forte di là di un apparato spettacolare pur splendidamente realizzato, di là di una gestualità drammatica purgata da ogni enfasi e ridotta al segno incisivo e nervoso di un recitativo assai semplice e nudo, di evidente ascendenza italiana e che certo dovrà avere sconcertato non poco ascoltatori usi ai sontuosi declamati della tradizione francese. Fondamentale a tal proposito suona ancora l’intuizione di Fedele D’Amico, il quale avvertì nel celebre “Allegro maestoso” in Do magg. dell’epilogo «che tutta l’opera era lode alle radici della vita, liberazione di energie cosmiche», esaltata pulsazione dionisiaca: la stessa che freme in tutte le fibre della musica rossiniana e che in questo glorioso estuario trova il suo sbocco supremo.
Ciò spiega il respiro lungo e profondo di questa musica, che pure si articola in forme aliene da ripetizioni e lungaggini; musica per la quale sembra di prammatica la qualifica di monumentale, quando invece di grandiosità e vitale possanza si tratta, pari alle acque di un grande fiume giunto alla foce. E spiega il suo aprirsi alle voci della natura: voci che già ancor prima di Mosè e de La donna del lago (si pensi alla straordinaria scena V del Secondo Atto di Aureliano in Palmira) avevano aperta una breccia nello splendido artificio del palazzo rossiniano e che ora, dalla sinfonia all’apoteosi finale, irrompono impetuosamente come vere protagoniste della vicenda, istituendo un’alternativa vitalistica e antropocentrica a quelle, oscure e paniche, di Weber o feeristiche di Mendelssohn. Giacché l’onnipresente natura rossiniana non è l’arcano, terrifico regno romantico delle Grandi Madri, ma è natura classicamente amica e compagna all’uomo nel suo viaggio terreno, ove il male è avvertito come incidente di percorso e dove le stesse vicende della storia vengono considerate da una prospettiva trascendente permeata di religioso ottimismo.
Da ciò lo sguardo lungo e a vasto orizzonte col quale Rossini sembra contemplare il mondo via via nascente dalla propria immaginazione: ove le passioni degli uomini, dall’amore senza speranza che affanna Arnold e Mathilde al patriottismo dei montanari svizzeri, dalla tenerezza che lega Tell ai propri cari alla crudeltà dei tiranni, sono avvertite come momenti di una liturgia della libertà celebrata nel tempio della natura. Un’ottica essenzialmente antirealistica che mal si accorda con i casi futuri del grand opéra, con il suo sforzo di mimesi storica, la sua plastica, violenta immediatezza di comunicazione espressiva, la rinunzia ad ogni esemplarità idealizzante a beneficio di un crudo laicismo di matrice radicalmente borghese.
Tutto ciò non poté non coinvolgere taluni procedimenti compositivi qui per la prima volta adottati dal compositore, come l’utilizzo sistematico di materiali tematici provenienti da un repertorio presunto etnofonico, ossia quei ranz des vaches, melodie cantate o suonate dai mandriani svizzeri e presumibilmente trascelte da un repertorio, Recherches sur les ranz des vaches ou sur les chansons pastorales des bergers de la Suisse, pubblicato a Parigi nel 1813 da Georges Tarenne. Lungi dall’impiegare questi motivi nella realistica immediatezza della citazione testuale, Rossini ne assimila le peculiarità al codice genetico del proprio linguaggio tematico, colorandolo di una specifica impronta che invano si cercherebbe nelle opere precedenti. Aggirando l’aneddotica della couleur locale (un’idea fissa del gusto romantico, massime di quello francese), il lessico melodico del Tell uscirà così rigenerato come da un sottile metabolismo nel quale verranno praticamente dissolte le scorie di quel rossinismo cui si era già votata anima e corpo la retorica melodrammatica coeva: percorrendo anche in questo la strada maestra dei grandi artisti, che si rinnovano lasciando sistematicamente in secco i propri imitatori.
Tale era stato l’impulso innovatore impresso alla propria produzione (che è dire tout court al melodramma italiano che conta) degli ultimi, mirabili anni napoletani e proseguito a Parigi nelle rielaborazioni del Mosè e del Maometto, che Rossini si era trovato per così dire proiettato fuori orbita, in una posizione privilegiata che gli permetteva di dominare le strutture dell’opera sia francese sia italiana dall’alto di un’autonomia stilistica che non ha eguali storici, tranne forse che nell’Idomeneo mozartiano. Ben lungi, quindi, dall’adeguarvisi, egli adattò spregiudicatamente a propria misura il patrimonio estetico-strutturale dell’opera francese, creando quell’unicum che contemporanei e successori per lo più doppieranno come un’isola erta e perigliosa, preferendogli modelli più accessibili: per gli operisti italiani, quelli offerti da Auber, Halévy, Meyerbeer.
A rendere più inattaccabili le mura di diaspro di questa nuova Gerusalemme del teatro in musica, soccorreva la loro classica perfezione formale, esaltata da una scrittura orchestrale di rinnovata ricchezza e finezza, concepita in termini di sostanziale autonomia a fronte degli esempi di Cherubini e di Spontini come del sinfonismo viennese. Quella stessa che cementando in unità non meno strutturali che ideali i diversi episodi che formano l’introduzione al Primo Atto e il finale del Secondo, ne faceva dalle macrostrutture d’inaudita ampiezza e novità di concezione, sciolte da qualsiasi ipoteca storica nei confronti delle civiltà melodrammatiche italiana e francese: temeraria sfida stilistica conclusasi con una strepitosa vittoria.
Per altro verso, chi mai potrebbe avvertire sentor di polvere di palcoscenico francese nella romance di Mathilde «Sombre forêt, désert triste et sauvage», introdotta da uno tra i più trafiggenti preludi sinfonici mai inventati, non che da Rossini, da tutto il teatro musicale romantico e proiettata in un anelito schellinghiano verso l’unità tra spirito e natura? E come assimilare il «Sois immobile» di Tell, col suo incontenibile empito lirico accolto entro una cornice di classica e si direbbe religiosa compostezza, alla tradizionale retorica del declamato francese? (qualcosa di analogo è semmai da ravvisare nei brevi, fervidi ariosi che nelle opere di Spontini – si veda quello di Licinius nella Vestale, II, 3 – tengono il luogo di un récit o di un air).
Altrove vediamo Rossini muoversi in tutto lo spirito di libertà e spregiudicatezza lessicale che è proprio ai sommi artisti giunti al vertice della propria ascesa, i quali (si vedano l’ultimo Mozart o l’ultimo Beethoven) assimilano presente e passato in una realtà stilistica polimorfa, ma dall’impronta inconfondibilmente univoca. Ecco quindi, nel finale primo, dove assistiamo alla violenza degli sgherri di Gesler contro gli abitanti di Burglen, pervenire a piena definizione quel concertato dalla parte centrale improntata a una cantabilità dispiegata su progressioni armoniche di crescente empito emotivo, maturato da Rossini negli anni napoletani e prossimo a diventare tipico del melodramma italiano degli anni Trenta-Quaranta. Ed ecco invece, nell’Aria di Mathilde «Pour notre amour plus d’espérance», posta ad apertura del Terzo Atto e malauguratamente destinata a sparire assai presto dalla prassi esecutiva, Rossini recuperare per la seconda volta, dopo il Moïse (Aria di Anaï «Quelle affreuse destinée», IV, 2) un tipo di “Allegro agitato” vocale d’impronta classicheggiante e sonatistica, del quale abbiamo un riscontro egregio risalendo a Otello (Aria di Desdemona «Che smania! ohimè! che affanno!», II, 9) ma che ormai, a fronte della struttura formale costituita da cantabile-tempo di mezzo-cabaletta, in auge in quegli anni (e di fatto utilizzata nell’Aria di Arnold «Asile héréditaire», IV, 1) poteva considerarsi desueto.
Tra le scelte di assoluta autonomia stilistica e quasi tra le pieghe di una ricchezza e multiformità inventiva che fanno del Tell un cimento stilistico unico e non ripetibile, figurano infine certi episodi che preludono alle pagine decantate e cesellatissime dei Péchés de vieillesse per pianoforte, o iperstilizzate della Petite Messe Solennelle. Si osservi a tale proposito il chœur «Ciel, qui du monde» e il preludio orchestrale che lo precede (I, 6) e vi si noterà quel gusto, tutto cameristico e qualche poco calligrafico, di miniare con sempre cangianti e delicate ombreggiature armoniche frasi, semifrasi, incisi ricorrenti nel decorso inventivo.
La libertà di movimenti lungo un arco di opzioni lessicali e formali d’impressionante ampiezza; la massima attenzione rivolta ai valori drammatici fatti coincidere con quelli formali in virtù di uno sforzo di identificazione che ha del miracoloso; l’anelito, infine, a una continuità drammaturgica avvertibile in tutta l’opera come progetto ideale e almeno nei primi due atti come realtà effettivamente conseguita, sono dunque i tre elementi basilari sui quali Rossini ha eretto il proprio monumento, o se più piace, mausoleo. Di essi è manifesto l’atipica ouverture quadripartita che assimila e supera la pur incantevole componente descrittivistica in un epos esaltante e commosso: quell’“atmosfera morale” che il più enigmatico ma perciò stesso più spiritualmente grande tra i nostri maggiori musicisti poneva alle radici della propria arte.
Giovanni Carli Ballola
Pubblicata il : 7 aprile 2020