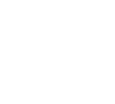Perchè vedere La cambiale di matrimonio
Venezia: la città più felice del mondo, secondo Stendhal. Una ex capitale in declino, secondo gli storici, dopo la fine della Serenissima repubblica (1797). Siamo nel 1810; governa chi quella Repubblica l’ha fatta morire – Napoleone Bonaparte; l’Europa è in guerra da quasi vent’anni; l’inflazione è alle stelle; tuttavia c’è una cosa a cui nessuno si sentirebbe di rinunciare, avendo anche solo qualche spicciolo in tasca: una sera a teatro. Ogni anno a Venezia si producono nuove opere, si pubblicano commedie e tragedie; la città di Goldoni ha ceduto il dominio sulle onde del mare ma non quello sulle scene. È lì, in un piccolo teatro sito vicino alla chiesa di San Moisè, che il 3 novembre, quasi inosservata – ma con discreto successo – viene rappresentata una farsa, ossia una piccola opera in un atto, dal titolo La cambiale di matrimonio. È l’esordio di un giovane compositore che vive e studia a Bologna, ma è nato a Pesaro diciotto anni prima, di nome Gioachino Rossini. Un raccomandato, perché non sempre le raccomandazioni promuovono gli immeritevoli, catapultato nella stagione d’Autunno del San Moisè perché un compositore tedesco (Johann Caspar Aiblinger) ha improvvisamente dato forfait. A sostituirlo, Rossini viene caldeggiato da una coppia di musicisti, Rosa Morandi, cantante in forza al teatro, e il marito Giovanni, compositore, amici della famiglia Rossini – che è un’altra famiglia di musicisti. Gioachino ha composto già molta musica e sta scrivendo o ha già scritto un’opera seria, è conosciuto a Bologna e Ravenna ma non al di fuori di quel breve percorso. L’impresario Antonio Cera dà fiducia al giovanotto che prende il libretto della vecchia volpe Gaetano Rossi e in poche settimane lo mette in musica. Il resto è storia, anzi, leggenda.
Perché si dice che i cantanti non siano felici della musica complessa scritta da Rossini (diciamolo, i musicisti più esperti non vedono l’ora di cogliere i novellini in fallo); si dice che il diciottenne dopo le prime prove scoppi in un pianto dirotto; si dice che uno dei cantanti (il grande buffo Luigi Raffanelli) impietosito gli dia un paio di consigli; che Giovanni Morandi ponga mano alla musica; insomma che non tutto sia andato liscio ma che alla fine il ragazzo abbia trionfato. Leggenda, appunto, o storia? Per scoprirlo non c’è che un modo, venire a Pesaro ad agosto 2025.
Perché a Pesaro quest’anno il Rossini Opera Festival metterà in scena La cambiale, e sarà la prima volta nell’edizione critica curata da Eleonora Di Cintio per la Fondazione Rossini. L’edizione critica non serve soltanto a farci sentire l’opera con la musica ascoltata nel 1810 (cosa che comunque fa, depurandola di tutte le incrostazioni di due secoli grazie al minuzioso studio delle fonti disponibili), ma a vedere un’opera d’arte nella sua interezza, svelandone la storia, scoprendone le motivazioni e in definitiva a farla parlare, a farci interagire, noi contemporanei, con l’opera del passato. Perché, ad esempio, un passaggio di un duetto fu tolto prima della prima? forse proprio perché troppo complicato? perché il ruolo della protagonista fu scritto così? perché quei pezzi, in quella posizione, e non altri? che cosa significava La cambiale nel periodo in cui fu composta, e che significa per noi oggi? Questo è il compito dell’edizione critica (di questa come di tutte le altre preparate dalla Fondazione Rossini): non frapporsi ma anzi svelare e lasciar vedere in trasparenza, mettendosi a disposizione dello spettatore e degli interpreti. Dopo aver pazientemente ricostruito la genesi, le vicende, l’importanza della Cambiale nell’epoca e nella biografia di Rossini possiamo ancor meglio godere dell’ora abbondante di puro divertimento che ci garantisce.
L’intreccio è divertente: una coppia di affaristi bizzarri (Mill, inglese; Slook, canadese, che nello spettacolo del ROF si presenta accompagnato da un ancor più bizzarro “amico” – che non sveliamo) che trattano il matrimonio di una ragazza (Fannì) “per lettera di cambio”, come fosse una merce che Slook deve ritirare; lei però ama un giovane (Edoardo), il quale si introduce in casa grazie ai buoni uffici dei due impiegati di casa Mill, Clarina e Norton, per scongiurare il matrimonio. Alla fine lo ”straniero” darà prova di una generosità senza pari e renderà possibile il sogno d’amore di Fannì ed Edoardo. Un apologo in cui non manca la consueta galleria di vizi e manie (ma anche virtù) umane.
Poi, c’è la musica di Rossini, che è quel formidabile conduttore di elettricità che conosciamo: procede a passo svelto, mette per la prima volta in campo tutte quelle frasi, quei tic, che risentiremo in seguito, mai uguali, sempre sorprendenti. Ogni personaggio ha la sua cifra, ogni situazione viene scolpita dalle note. Il ragazzo ha un grande avvenire davanti a sé, ed ha un talento immenso cui attingere.
Certo, se la famiglia Rossini non fosse stata amica della famiglia Morandi? E se un compositore tedesco non avesse dato forfait all’ultimo? E se l’impresario del San Moisè non avesse ascoltato le raccomandazioni di chi gli parlava di un fenomenale compositore appena diciottenne? insomma, se non ci fosse stata La cambiale di matrimonio, Gioachino Rossini sarebbe comunque diventato Rossini? Probabilmente sì: ma nell’assistere alla prima opera rossiniana rappresentata possiamo porci una serie di «what if…», sollevati dal fatto che non solo la storia sia andata così, ma che ci abbia lasciato in eredità un piccolo gioiello da riscoprire. Perché anche oggi, come nel 1810, a una cosa non riusciamo davvero a rinunciare: a una magnifica serata in teatro.
Daniele Carnini – Direttore editoriale della Fondazione Rossini
Pubblicata il : 29 Marzo 2025